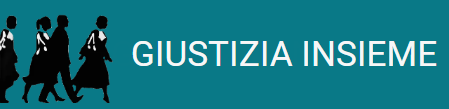Quando la resistenza si fece scioperando
Sono le 13.50 del 16 giugno 1944 quando massicci reparti della Divisione Alpina tedesca circondano gli stabilimenti di quattro industrie genovesi, Ansaldo, Piaggio, Siac e San Giorgio, in sciopero dai primi giorni di giugno per l'insostenibile aggravarsi delle condizioni di vita in città. Il cibo ormai scarseggia, le scorte alimentari sono esaurite ed è improbabile che i rifornimenti arriveranno dal mare: i bombardamenti che si succedono interessano infatti il porto e i ponti delle vie che vi sono dirette, oltre al centro città e alle periferie industriali. L’11 marzo le bombe sganciate sui i quartieri di Sestri Ponente, Pegli, Sampierdarena e Rivarolo avevano causato 40 vittime, tra morti e feriti; fra il 23 ed il 30 aprile si erano contati 17 morti e 30 feriti; 90 invece le vittime del bombardamento del 4 giugno a Cornigliano, Rivarolo e Sampierdarena.
Genova è in fiamme. Arde la città e ardono gli animi dei suoi operai. Affamati ed esausti per i turni di lavoro infiniti, alle 10 dell’1 giugno scendono in sciopero nell’industria Fossati, nel Cantiere Ansaldo, nello stabilimento San Giorgio. Ma lo sciopero è un diritto ancora lontano.
La protesta infervora gli uomini. La repressione, però, arriva veloce. Già alle 16 dello stesso giorno piombano negli stabilimenti forze di polizia italiane e militari tedeschi. Sono in numero nettamente superiore: ad armi spiegate occupano il Cantiere Ansaldo, arrivando a uccidere un operaio manifestante. Poi radunano 64 operai, portandoli via su un camion. È l’avvisaglia della tragedia di sei giorni dopo.
Il Comitato Nazionale di Liberazione dà ordine di non retrocedere: “non debolezze né impazienze”[1]. Giungono incoraggianti le notizie della liberazione di Roma e dello sbarco alleato in Normandia. Continuare la protesta però è difficile: mancano forze e mezzi e vi sono ostacoli da ogni versante: il prefetto, timoroso di quanto potrebbe accadere a lui stesso, invita perentoriamente a cessare la rivolta[2], per poi dispiegare nuove forze in ausilio al numero già soverchiante di truppe tedesche.
Il destino degli scioperanti si compie infine alle 19 del 16 giugno 1944, quando, al termine dei rastrellamenti durati l’intero pomeriggio, in 1.488 vengono caricati sui carri ferroviari alla stazione di Genova Campi, strappati alle loro famiglie e deportati a Mauthausen. Molti di loro non torneranno.
Quei lavoratori affamati e stremati improvvisarono un’azione con la quale, grazie al generoso sacrificio comune, credettero di potere migliorare le esistenze di tutti e di ciascuno. La loro ribellione alla schiavitù di un lavoro forzato destinato alla produzione bellica ebbe un ampio, ma forse non generale riconoscimento[3]. Eppure anche alla resistenza operaia in fabbrica dobbiamo i diritti sociali e di libertà scritti oggi in Costituzione.
Chiara Semenza
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.