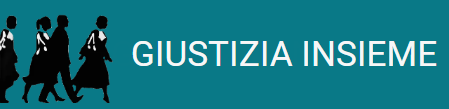Era di maggio...
(il leader dell’antimafia sei tu)
“…per noi palermitani il 23 maggio è un giorno eccezionale, ma per il resto d’Italia no…fa specie la difficoltà di spiegare ai giovani di oggi che non è un capitolo chiuso…le stragi…riguardano anche loro, non è storia passata…”.
Scrivere oggi 22 maggio 2024 per questa rubrica è complicato: il pensiero va inesorabilmente alle stragi del ’92, e il rischio di cadere nella retorica è in agguato. Ho deciso allora di ricordare in apertura quello che ha detto un artista come Pif al nostro meraviglioso Congresso ANM di Palermo, con la sua capacità di parlare con leggerezza di argomenti potenti; e che ha continuato a risuonarmi nella testa per giorni.
Ma davvero per il resto d’Italia il 23 maggio non è un giorno eccezionale?
Probabilmente non è vero; ma è altrettanto probabile che il peso e il significato di quegli eventi siano condizionati da una serie di variabili, non ultima delle quali quella generazionale. Sicuramente, poi, quella che potremmo definire del contesto umano e sociale di riferimento: per chi tra noi in quel periodo studiava all’università, o si preparava per il concorso, o magari era già in magistratura, anziano o giovane che fosse, le stragi di Capaci e di via D’Amelio hanno rappresentato e rappresentano tuttora una pietra d’inciampo della nostra coscienza di magistrati, un pesante e inevitabile punto di riferimento con il quale fare i conti.
Innanzitutto per la straordinaria lezione che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno lasciato a chiunque tra noi si sia occupato in seguito di criminalità organizzata di stampo mafioso: un metodo – fondato su indagini patrimoniali, collaboratori di giustizia, coordinamento nazionale e cooperazione internazionale - che ha connotato in seguito non soltanto i protocolli investigativi ma anche le regole valutative più adeguate per una intelligente ed efficace ricostruzione e qualificazione del fatto.
“Trent’anni fa la lotta alla mafia era una follia, e grazie a quella follia noi viviamo meglio…” (ancora Pierfrancesco, in arte Pif, a Palermo): per quella follia hanno dato la vita uomini pericolosamente convinti che la mafia sia sempre stata strutturalmente connessa alla politica, all’imprenditoria e alla finanza. Non per nulla ieri, nella Relazione della DIA del ‘93, si leggeva delle commistioni tra la mafia e finanzieri d’assalto, funzionari dello Stato infedeli e pubblici amministratori corrotti tra le forze occulte di un mondo oscuro intenzionato ad ostacolare in ogni modo il metodo innovativo attuato da Giovanni Falcone.
Affermazione che ritroviamo nella sentenza della Corte d’Assise di Caltanissetta del 9.12.99 (c.d. Borsellino ter) dove è scritto che la morte di Borsellino, oltre che per finalità di vendetta, era stata voluta anche per realizzare una forte pressione su quegli esponenti politici che avevano intensificato l’azione di contrasto alla mafia, e per indurre “nuovi possibili referenti” a farsi avanti al fine di negoziare un mutamento di quella linea politica.
Non solo dalla mafia militare, dunque, sono stati ammazzati Falcone e Borsellino. E non soltanto per eliminare magistrati scomodi, ma per una più complessa e raffinata strategia politico-affaristica alla quale occorre ancora oggi opporre contenimento e reazione non solo con la leva penale ma soprattutto con consapevolezza e azioni di tipo culturale e sociale.
Comprendere questo è l’altro straordinario insegnamento che ci hanno lasciato, e che ancora una volta leggo nelle parole pronunciate da Pif a Palermo in questo maggio del 2024: “secondo me non cambierà mai niente se la lotta alla mafia è considerata non una questione solo penale tecnica ma una questione morale...è questo lo scatto…per non essere deluso dalla lotta dell’Antimafia devi decidere che il leader dell’antimafia sei tu…io voglio il panettiere antimafia, il benzinaio antimafia, il cameraman antimafia…sennò è troppo comodo…”.
Giovanni Falcone volle in tutti i modi che il maxi-processo fosse celebrato a Palermo, perché “…a Palermo abbiamo lavorato, perché la mafia è a Palermo e perché la risposta deve essere data a Palermo”. Il potente valore morale e politico di quella scelta dimostra quanto sia importante ricordare Giovanni, Paolo e tutti gli altri come persone vive, “perché noi facciamo un’ingiustizia quando ci concentriamo sulla loro morte, perché noi dobbiamo ricordare com’è che ci sono arrivati a morire così: è quella la loro forza…” (ancora Pif, 12 maggio 2024, Palermo, Congresso ANM).
Ida Teresi
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.