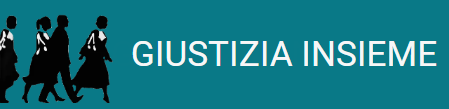Un giorno tra Hiroshima e Palermo
Il 6 di agosto è giornata significativa perché evoca un accadimento epocale: l’utilizzo su Hiroshima della prima bomba atomica. “Little boy”, così fu soprannominata, venne sganciato all’alba del 6 agosto 1945 su uno dei centri industriali giapponesi di maggiore importanza, pure per la presenza di alcune basi militari, provocandone la distruzione e più di 200.000 vittime, tra quanti morirono subito e quanti perirono a distanza di a causa delle devastanti conseguenze delle radiazioni.
Fu l’inizio di nuova fase, l’ultima, della seconda guerra mondiale, la fase che avrebbe portato di lì a poco alla tragedia analoga di Nagasaki e poi alla resa del Giappone. Un sottilissimo filo lega quella drammatica vicenda ad altre che ci hanno toccato più da vicino, seppur con le dovute e innegabili differenze: a Hiroshima si trovava padre Pedro Arrupe, gesuita attento ai poveri e alla giustizia sociale, a cui sarà in seguito dedicato a Palermo l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, voluto dai gesuiti siciliani come luogo d’incontro e di studio in particolare per quanti hanno responsabilità nelle istituzioni.
Erano proprio quelli anni caratterizzati, a Palermo, da un altro conflitto: la “seconda guerra di mafia”. E ritorna anche qui il 6 agosto: nel 1980, in una calda sera d’estate, viene ucciso il procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa. Costa era stato partigiano, impegnato in Val di Susa durante la Resistenza, e, finita la guerra, aveva vinto il concorso in magistratura, svolgendo per gran parte della carriera le funzioni a Caltanissetta, sino al trasferimento a Palermo, quale procuratore capo della Procura presso il Tribunale. Dal suo arrivo nel capoluogo aveva innovato i metodi di indagine, comprendendo – insieme a Rocco Chinnici che nel frattempo era diventato consigliere istruttore – quanto importanti fossero le verifiche sui patrimoni nella lotta a Cosa nostra.
Ma nel suo ufficio Costa non aveva trovato il supporto dovuto e meritato, tanto da trovarsi solo nei momenti più delicati della sua attività investigativa, sino al proprio brutale omicidio. I semi del suo lavoro non andarono comunque dispersi: poco tempo dopo, nel luglio del 1982, su attività congiunta di polizia e carabinieri, venne redatto il cosiddetto “rapporto dei 162”, che disegnava per la prima volta l’organigramma delle famiglie mafiose.
Tra coloro che firmarono quel rapporto vi era anche Antonino (detto Ninni) Cassarà, che il 6 agosto di tre anni dopo, nel 1985, da vicequestore, cadde, con l’agente Roberto Antiochia che l’accompagnava, sotto i colpi di mitra sparati mentre stava rientrando a casa, a pochi giorni da altro omicidio eclatante, quello del commissario Beppe Montana, capo della sezione “catturandi” della Questura di Palermo.
Nel trentennale delle stragi del 1992, è del pari importante ricordare coloro che posero le basi del metodo di lavoro del “pool antimafia” dell’ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, sino alla stesura della ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio che avrebbe dato il via al maxi-processo di Palermo apertosi nel 1986.
Quel filo rosso che, attraverso la data del 6 agosto, lega tra loro eventi tragici, porta infine al ricordo di un’affermazione di legalità.
Giuseppe De Gregorio
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.