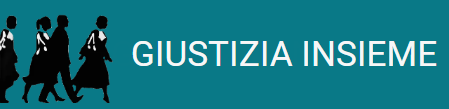Petrarca e il nostro tempo
Il 9 novembre 2020 muore Marco Santagata: professore universitario, medievista, critico letterario, scrittore. Tra i massimi studiosi di Petrarca (di cui ha curato "il Canzoniere" per i Meridiani Mondadori: un certificato di garanzia), con le sue raffinate narrazioni è stato, tra l’altro, vincitore del premio Campiello (2003) e finalista del premio Strega (2015). Con lui, come con pochissimi altri nella letteratura contemporanea (mi viene in mente solo Umberto Eco) il rapporto circolare tra vita e letteratura si arricchisce di un ulteriore, preziosissimo elemento: l’oggetto di studi accademici inaccessibili ai più, in cui - da un lato - si trasfonde la vita dello studioso e che - dall'altro - divengono letteratura.
Memorabile, in questo senso, "Il copista. Un venerdì di Francesco Petrarca" (2000): un cammeo della narrativa italiana, troppo poco conosciuto - non foss'altro che ogni uomo di lettere si può riconoscere in questo Poeta dissacrato, ormai anziano, puttaniere bestemmiatore alcolizzato depresso; tutto ciò che probabilmente Petrarca è stato. Nel "Copista" la scrittura è precisa, e precisamente, con taglio caravaggesco, rende drammaticamente la scena e il suo personaggio. E che personaggio: un vecchio che bamboleggia, un sommo poeta incapace di invettiva, ritratto in tutta la sua umanità, lacerato dai propri fallimenti. Lo stile è quello di un classico di altri tempi (è ora, d'altronde, di cominciare a pensare a Santagata come a un classico), centrato su un personaggio boccaccesco - tale era il Petrarca - e i suoi ricordi, dolorosi, sfalsati, eppure intrecciati in uno stile a metà strada tra la coscienza di Svevo e l'incessante rimuginio familiare della Ernaux (da oggi, col Nobel, pure lei un classico).
Ma il racconto che Marco Santagata metteva in scena vent'anni fa è, per i lettori d'oggi, un volano formidabile per riflettere sul presente, sul rapporto tra le arti e la politica, ed ancora più specificamente tra gli uomini di governo e gli uomini di lettere. Un tema di vertiginosa attualità, in un momento storico in cui la cultura è vista come grazioso orpello della civiltà moderna, un ghirigoro del tutto inutile; figuriamoci quale apporto può dare all'esercizio del potere.
In Italia, soprattutto. Perché in Italia è da almeno trent'anni che questo rapporto virtuoso si è interrotto. Era in piedi da secoli: i potenti del tempo di Petrarca facevano a gara per ottenere un incontro, una conversazione con il poeta, una sua missiva; agognavano, per avere consigli su un saggio esercizio del potere. Le arti erano viste come un arricchimento: “Fare visita al poeta in campagna era diventato una specie di obbligo; l'essere ricevuti nella sua modesta casetta un privilegio di cui vantarsi”. Filosofare con gli artisti e i letterati è stata una pratica comune in ogni epoca storica (cosa è stato l'Umanesimo? e cosa l'Illuminismo?), con l'evidente eccezione dei buchi neri delle dittature e degli autoritarismi: quelli passati, quelli presenti e quelli ahimè futuri. Una pratica coltivata fino a tempi recenti, anche in Italia, dal dopoguerra in poi. La politica si interessava delle arti, e viceversa. Ancora negli anni Ottanta Renato Guttuso era senatore tra le file del PCI, Leonardo Sciascia deputato radicale, Giovanni Spadolini il leader del partito repubblicano, Eduardo de Filippo senatore a vita. E poi, cos'è accaduto?
Qualcosa di molto simile al decadimento fisico dell'uomo che non ha più voglia di vivere e che attende la morte; come il memorabile Petrarca di Santagata, che scorge nella sua condizione “una perdita continua, disordinata, casuale. Il mondo rimpiccioliva e la vita si abbreviava fino a coincidere con un vuoto presente”. Eccolo, il vuoto presente; ciascuno di noi, nel suo piccolo, può provare a riempirlo.
Andrea Apollonio
Il Passato talvolta ritorna.
Se non ritorna, forse non è passato.
Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.
Attendiamo i contributi di tutti.