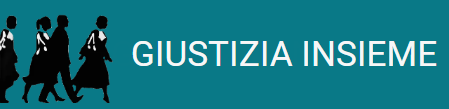Diario dal Consiglio del 15 novembre 2025
Nuovo femminicidio, aspettando investimenti e risorse
Nella seduta del 5 novembre il Plenum ha emesso il parere sul disegno di legge intitolato “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, attualmente all’esame della Camera nel testo licenziato dal Senato (significativamente ampliato, con il passaggio da 8 a 14 articoli, rispetto a quello originariamente presentato dal Consiglio dei ministri).
Anche in questo caso, come già a proposito del recente parere sul disegno di legge delega sull’intelligenza artificiale (ma diversamente dalla prassi prevalente degli ultimi anni), il parere ex art. 10 l. n. 195/1958 non è stato avanzato di iniziativa consiliare ma è stato richiesto dal Ministro della giustizia, con specifico riguardo alle previsioni riguardanti l’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero e la formazione dei magistrati “salve ulteriori implicazioni per l’amministrazione della giustizia correlate all’impatto delle diverse disposizioni recate dal DDL”.
Rimandando al testo della delibera per una visione completa delle considerazioni svolte dal Consiglio, evidenziamo qui i punti principali.
La delibera – concentrandosi sull’impatto che la nuova normativa avrà sugli uffici giudiziari – non affronta il tema, fortemente dibattuto nella dottrina penalistica e tra gli operatori del diritto, della opportunità della scelta legislativa, sommamente politica, di introdurre nell’ordinamento il nuovo delitto di femminicidio (così descritto nel testo del disegno di legge licenziato dal Senato: ”Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo”). Al riguardo il parere si limita a sottolineare, da un lato, le notevoli difficoltà probatorie dell’accertamento giudiziale del fatto che l’omicidio di una donna sia stato commesso “come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna” e, d’altro lato, la parziale sovrapponibilità del riferimento normativo al “rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo” alla vigente aggravante di cui al comma 1, n. 1, dell’art. 577 c.p., a mente del quale si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 c.p. è commesso “contro il coniuge anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad essa legata da relazione affettiva”.
Ancora, la delibera esamina – ed apprezza – la scelta legislativa di potenziare la formazione dei magistrati. Il disegno di legge interviene sul testo dell’articolo 6 della legge n. 168/2023, che dettava “iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, fornendo una più dettagliata specificazione dei contenuti e delle caratteristiche dei corsi formativi in tali materie e prevedendo l’obbligatorietà della partecipazione ad almeno uno di tali corsi formativi per i magistrati assegnati alla trattazione, anche in via non esclusiva, di procedimenti in materia di famiglia o di violenza domestica contro le donne o materia a esse connesse. Nel parere, tuttavia, si sottolinea, per un verso, che l’effettivo perseguimento della diffusa formazione specialistica in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica richiederà la predisposizione, da parte del Ministero, delle risorse necessarie alla sua effettiva realizzazione; per altro verso, che il riferimento alle “materie connesse” a quelle della “famiglia” o “violenza contro le donne o domestica” appare eccessivamente generico per risultare idoneo a costituire il presupposto dell’insorgenza di un obbligo formativo in capo al magistrato.
La delibera poi esamina le disposizioni del disegno di legge che rimodulano le modalità di controllo sull’osservanza, da parte dei magistrati delle procure della Repubblica, del dovere di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia della notizia di reato.
Il disegno di legge, infatti, nell’intervenire sull’art. 2 d.lgs. n. 106/2006, laddove esso prevede il potere del procuratore della Repubblica di revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento al magistrato che non osservi le disposizioni di cui all’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., sopprime le disposizioni che conferivano al magistrato destinatario della revoca la possibilità di presentare osservazioni scritte nonché quelle che imponevano al medesimo procuratore di provvedere senza ritardo, direttamente o tramite assegnazione ad altro magistrato, ad assumere informazioni della persona offesa.
Nella delibera si evidenzia come le ragioni dell’abrogazione della facoltà di presentare osservazioni alla revoca non emergono dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge e non sono facilmente intellegibili, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il CSM di (continuare a) disciplinare l’esercizio del potere di revoca in sede di normazione secondaria e di prevedere forme di contraddittorio endoprocedimentale pur in assenza di una norma primaria.
Quanto al dovere del procuratore della Repubblica che abbia revocato l’assegnazione di provvedere senza ritardo, direttamente o tramite assegnazione ad altro magistrato, ad assumere informazioni della persona offesa, tale dovere deve ritenersi implicito nel sistema, con la conseguenza che la soppressione della disposizione che lo menzionava espressamente non esclude che esso permanga in capo al procuratore o in capo al magistrato che dal medesimo sia stato designato in sostituzione del precedente titolare del procedimento.
Nella delibera si evidenzia altresì come, nell’intervenire sull’art. 2 d.lgs. n. 106/2006 – che attualmente prevede che il “procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale” – il disegno di legge aggiunga, ai dati da richiedere, anche quelli “relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero”. Si tratta, all’evidenza, di un ulteriore onere che va a gravare sulle procure generali della Repubblica.
Da ultimo vale la pena di evidenziare che nella delibera si dedica un’attenta riflessione alla disposizione di carattere procedurale relativa all’obbligo (derogabile) di audizione diretta da parte del pubblico ministero della persona offesa che abbia al riguardo presentato tempestiva e motivata richiesta. Vi si evidenzia come l’impatto di questa norma sugli uffici dipenderà dalla percentuale (oggi non prevedibile) di denunce per reati di codice rosso che saranno accompagnate da una “motivata” e “tempestiva” richiesta di audizione personale condotta direttamente dall’autorità giudiziaria. Non potendosi escludere che quasi ogni denuncia rechi la predetta richiesta, sembra inevitabile ritenere che le procure della Repubblica debbano assicurare la costante presenza di un numero di magistrati “specializzati” nel contrasto ai reati da codice rosso idoneo a soddisfare una quantità di richieste assai elevata, ciò che potrebbe risultare in concreto tutt’altro che agevole, soprattutto per gli uffici giudiziari di medie e, soprattutto, piccole dimensioni.
Il Consiglio ha quindi evidenziato il rischio che la concentrazione dell’impegno nella fase dell’audizione diretta determini l’impossibilità per il pubblico ministero di assolvere tempestivamente agli ulteriori incombenti propri della sua funzione, tanto con riferimento agli altri procedimenti in materia di codice rosso di cui egli sia titolare, quanto con riferimento ai procedimenti relativi a reati diversi da quelli concernenti la violenza domestica o di genere a lui parimenti assegnati.
All’esito di un approfondito dibattito la delibera è stata approvata all’unanimità. Un’ultima notazione: era da tempo che non accadeva che un parere del Consiglio ex art. 10 l. n. 195/1958 venisse approvato all’unanimità.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello